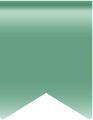Monti Picentini: la prima Alta Via del Mezzogiorno
Fra il giugno ed il dicembre 1984 mi trovo partecipe di una intensa esperienza che ha per teatro d’azione i monti dell’Appennino della Campania. Un cliente della nostra scuola d’arrampicata, il professor Fabrizio Braccini, ci mette in contatto con la Pro Loco di Acerno, piccolo borgo dell’entroterra fra Salerno e Battipaglia, annidato nei Monti Picentini. Anche sotto suo consiglio, la Pro Loco, guidata da Donato Vece, ha in progetto di creare una Alta via dei Picentini.
«Perduti! Clamorosamente perduti in questi boschi che sembrano senza fine.»
Era solo il primo giorno di lavoro e già si rischiava di lasciare a metà la segnalazione del sentiero. Eravamo scesi nei Picentini un po’ troppo sicuri di noi stessi e ora pagavamo la nostra superbia. Avevamo delle vecchie carte IGM al 25.000 e su di esse Fabrizio aveva tracciato i percorsi che avremmo dovuto segnalare. Una rapida occhiata ci fece decidere che tutto il lavoro si poteva fare in pochi giorni, ma allora non sapevamo ancora niente di quei monti.
Lasciato il litorale campano fra Salerno e Battipaglia entrammo nella terra che una volta fu regno dei briganti seguendo una strada tutta curve che si immerge nel verde di ombrosi valloni e conduce ad Acerno, la nostra base operativa. Il giorno successivo ci vide subito all’opera nel tentativo di aprire il sentiero n. 1, quello che da Volturara Irpina sale al Monte Terminio.
Un facile inizio portò a una strada carrozzabile che percorremmo per circa due chilometri; al suo termine ci immergemmo nel fitto bosco. Un vallone sulla sinistra sembrava coincidere in qualche modo con la lettura della carta. Forse eravamo sulla strada giusta e la debole traccia sul crinale che stavamo percorrendo era abbastanza incoraggiante.
Ogni dieci metri circa entrava in funzione il pennello e un nuovo segnale arancione indicava il progresso verso l’ignoto. «Se non altro – scherzava Giulio – tutti quei segni ci serviranno per poter tornare indietro quando ci perderemo come Pollicino.»
Tutto andò per il meglio fin quasi sotto la cima dove il sentiero si perse e dove, ad aumentare le difficoltà, trovammo la neve che già più in basso, riempiva alcuni canaloni: il fitto fogliame della faggeta impediva al sole di sciogliere il manto indurito e quasi gelato, ma certo non avremmo mai immaginato che in giugno, a soli 1500 metri e per di più nell’Appennino meridionale ce ne fosse ancora un buon metro.
Senza sentiero e senza direzione, dal momento che la neve copriva ogni eventuale segno di passaggio, in mezzo alla fittissima selva, eravamo proprio nei guai.
Per più di un’ora, cercammo a destra e a sinistra, tentando di uscire dall’impasse. Dei sentieri segnati sulla carta e che avrebbero dovuto trovarsi nelle vicinanze, non c’era neppure l’ombra. Anni di abbandono e migliaia di foglie li avevano inghiottiti e riportati alla pendice del monte.
Eravamo alla disperazione: cosa avrebbero detto le tronfie guide del Nord a chi, fidandosi di loro, sperava di creare l’Alta Via dei Picentini?
Fortuna volle che il “vecchio” Giulio potesse scoprire su un tronco uno sbiadito segno giallo e blu che iniziava proprio nei pressi del punto dove avevamo perso ogni traccia. Seguendo i bolli antichi e apponendo i nostri nuovi riuscimmo ad arrivare alla stupenda conca erbosa che sta fra le vette del Terminio. La neve finiva, per lasciare il posto ad un verdissimo prato punteggiato da migliaia di viole e da altri fiori di alta quota.
Dalla vetta di destra la vista era estesissima e sotto di noi potevamo scorgere Volturara e il verde tavolato carsico della Piana del Dragone. Nei nostri giri molte altre volte avremmo visto quei magnifici piani carsici che interrompono un po’ ovunque la continuità del bosco e contribuiscono a fare dei Picentini il più importante bacino idrografico del Meridione.
Ma questi piani non costituiscono certo un problema per il camminatore, mentre tutta la complessa rete di vallette e valloni, creste e cime è un vero labirinto.
Dopo aver rischiato il bivacco sulla SS. del Terminio, raggiunta finalmente dopo ore e ore di marcia, e dopo esserci riposati a San Sossio, il giorno seguente segnammo un sentiero che, partendo dal paese porta anch’esso al Terminio.
Secondo il nostro progetto avremmo dovuto ricollegarci al tracciato del giorno prima in un punto preciso, in mezzo al bosco, dove si trovava una sorta di incrocio marcato da un vecchio ceppo di faggio. Ancora una volta, si partiva senza la certezza di dove si sarebbe andati a finire. Sapevamo che un sentiero avrebbe dovuto esserci, ma in un bel tracciato, chiaro e non infestato da vegetazione, c’era poco da sperare.
Fortunatamente all’inizio dell’avventura trovammo un rude conducente di mulo che stava salendo più o meno nella nostra direzione. Interrogato, ci spiegò che ormai sul monte non c’era più niente o quasi, che i sentieri erano abbandonati e a sua volta ci domandò perchè mai facessimo tanta fatica per ritrovarli visto che nessuno li percorreva. La nostra risposta di certo non lo convinse molto.
Sotto un sole implacabile salimmo con il nostro amico lungo un sentiero quasi coperto dal verde. Arrivati alla mulattiera principale, ci separammo e uomo e mulo salirono verso una ignota destinazione. Noi prendemmo la splendida mulattiera lastricata, a tratti, con blocchi di marmo, e spesso fiancheggiata da bellissime orchidee maculate. Tutto sommato sembrava che questa volta si andasse molto meglio. E invece la mulattiera terminò quasi improvvisamente e noi fummo di nuovo nei guai, cercando un itinerario decente che ci portasse più in alto.
Fu lassù che dal nulla ricomparve il nostro mulattiere che, quasi come il buon genio delle fiaba, ci soccorse, dandoci l’indicazione decisiva per proseguire: «Seguite quel tratto infestato di erbacce e sbucherete su un’area disboscata. Oltre quella troverete il vecchio sentiero per Volturara, seguitelo che per pochi metri e potrete imboccare la deviazione per Colla Castagno». Girato il mulo il genio se ne andò inghiottito dalla foresta e noi, dopo vari tentativi, riuscimmo a riprendere la marcia sul sentiero esatto.
Procedendo la faggeta si faceva sempre più fitta e imponente, ma la mulattiera “teneva” e riuscimmo ad entrare in un tratto di bosco che aveva qualcosa di familiare. Erano circa sei ore che segnavamo quel sentiero sperando di arrivare al sospirato incrocio oltre il quale saremmo tornati a Volturara per riprendere il furgone. Sei ore passate col naso incollato alla carta topografica, ma gli occhi attenti anche a splendidi luoghi ove il ricordo dell’uomo si era perso da anni. Alla fine la nostra pazienza fu premiata: al limite della fustaia sorse improvvisamente il ceppo rinsecchito che segnava idealmente l’incrocio.
Per la prima volta provammo una gioia che non era quella della vetta o del superamento di un difficile passaggio, ma quella della semplice soddisfazione di aver ritrovato quel punto, dopo ore di cammino alla cieca e della certezza di aver compiuto interamente la prima e forse più difficile parte dell’opera. Non la gioia dell’alpinista, ma quella dell’esploratore e del pioniere.
I giorni successivi furono anch’essi dedicati all’improba lotta contro muri di vegetazione, seguendo tracce e cercando di costruire un itinerario bello e agevole.
Ci muovemmo dapprima nel settore dei piani carsici del Terminio, quello dei Picentini occidentali, caratterizzato da forme più aspre e decise. Poi lentamente, segnando sentiero dopo sentiero ci collegammo al cuore del gruppo raggiungendo, attraverso la cima dell’Accellica (1660 m), la grande faglia ove scorre il Tusciano.
L’Accellica è forse la più ricca di storia fra le montagne dei Picentini. Si tratta di un’escursione un po’ impegnativa con alcuni tratti di roccia che, seppure facili, richiedono attenzione. Fra le scure rupi pare si andassero a nascondere i briganti della banda Manzo di Acerno, quando da queste parti sciamavano le squadre dei carabinieri in battuta.
Non trovammo le grotte e i cunicoli dei briganti e neppure quel canyon che, si diceva, attraversavano con una pertica che poi veniva tolta per impedire ai gendarmi di raggiungerli.
Tuttavia fra la nebbia impalpabile che ogni mattina incappucciava la vetta, sorgevano magnifiche e spettrali visioni che rendevano tutto misterioso e affascinante.
Sotto l’Accellica sta Acerno, il piccolo paese che per la sua posizione può essere a ragione considerato la capitale del gruppo montuoso. Il collegamento fra Acerno e l’Accellica lo facemmo tentando di ripetere il sentiero percorso dall’intellettuale alpinista Giustino Fortunato, nel corso della sua ascensione alla vetta.
Purtroppo l’intrico delle nuove strade, i disboscamenti e le tracce lasciate ovunque dal bestiame ci resero la vita impossibile e di certo il vecchio sentiero non fu percorso che in parte. A tutto ciò bisogna aggiungere che Fortunato nel suo L’Appennino della Campania (1884), non è certo stato prodigo di informazioni al riguardo.
Tuttavia collegando i vari tracciati ne uscì un itinerario molto interessante. Si inizia dalle rovine della terremotata e sfortunata chiesa di San Donato, passando poi fra i piccoli orti di Acerno. Per i pascoli e i boschi della Serra San Donato, si perviene infine alla grande cresta sommitale.
Oltre Acerno, verso Sud, la nostra fatica si concluse con la memorabile traversata del Polveracchio (1790 m) che, con una spettacolare cavalcata, ci portò fino a Senerchia. Per la sua posizione il Polveracchio è forse la più panoramica vetta dei Piacentini orientali. Dalla sommità lo sguardo spazia fino al golfo di Napoli a Nord e al Pollino verso Sud. La sua cresta, quasi totalmente libera da piante è un giardino fiorito dove si trovano numerose specie di fiori rari. Per più di un’ora camminammo fra orchidee gialle (orchis pallens) e viole che ci accompagnarono fino alla vetta.
Al termine di dieci giorni passati fra questi monti non potevamo che restare stupiti da ciò che avevamo visto, dalla natura ancora spesso incontaminata che si trova in molte zone, dalla particolare bellezza della caotica orografia.
Nonostante il sudore, le faticacce, la rabbia per i sentieri quasi introvabili, ci eravamo innamorati dei Piacentini e certo saremmo tornati per finire con due trasversali la nostra Alta Via.
Dicembre 1984.
Eccoci ancora ad Acerno per concludere. Il tempo non è dei più favorevoli, ma vogliamo iniziare subito il lavoro anche perché abbiamo solo sei giorni di tempo prima di tornare a casa, richiamati da altri impegni.
L’inverno è già sceso sui monti, i faggi formano una grigia patina che ricopre le pendici e i rigagnoli più magri d’acqua sono già ghiacciati.
In mezzo a un nebbione fittissimo tracciamo la prima trasversale, quella che dal Montagnone di Nusco (1493 m), attraverso il Cervialto (1809 m), arriva ad Acerno. Due giorni di umidità continua, ma senza pioggia, hanno fatto da preludio a quella che si è rivelata la nostra più bella giornata fra i Picentini: quella che passammo sui Mai. Infatti, dopo la prima trasversale toccava ora al collegamento fra i Monti Mai (1607 m) e l’Accellica.
La lunga cresta dei Mai è veramente stupenda e offre il più bell’itinerario della zona anche se richiede attenzione sempre desta. Si tratta di una lunghissima camminata che si sviluppa per oltre 12 chilometri sul crinale di una cresta prevalentemente rocciosa.
L’alba è stata stupenda con il sole radente che creava un magico gioco di luci fra le rocce e le piante mentre verso la piana di Battipaglia lievi nebbie iridescenti entravano dal mare facendo emergere ogni rilievo come fosse un’isola.
Ora il sole ha compiuto il suo cammino e assieme a lui noi ci avviamo alla fine del nostro. Di fronte il Terminio mostra tutto il suo possente versante meridionale. Rocce e pilastri sporgono da quella gigantesca ferita del monte che è il Vallone Matrunolo. A sinistra del vallone, una strada porta alla grotta dell’eremo di San Salvatore: sembra l’unica via d’accesso anche a quelle pareti che appaiono quasi inavvicinabili.
Mentre la luna sorge dal Varco del Faggio e il sole appena tramontato colora di rosa il Terminio noi ripartiamo dalla chiesa di San Michele dopo esserci un poco riposati.
Certo non si poteva sperare una conclusione migliore per la nostra fatica e per l’Alta Via dei Monti Picentini.