Iniziamo la stagione invernale con le ciaspole per l’anno 2024-2025 nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Le escursioni verranno organizzate sia diurne che notturne, sono adatte a tutti anche senza esperienza.
Categoria: Mondo Escursionismo
Le grotte spiegate in modo semplice
Cosa sono le grotte?
Sono vasti reticoli di cavità naturali che esistono all’interno di alcune montagne; a volte esse arrivano sino alla superficie esterna formando ingressi dai quali possiamo entrare a visitare o ad esplorare questi mondi bui percorsi solo da aria ed acqua. Ma attenzione: la grotta e’ nell’interno del monte e in genere per evolversi non ha affatto bisogno di ingressi percorribili. E’ per questo che pensiamo che buona parte delle grotte che esistono in realtà non siano accessibili. All’esterno arrivano indizi che ci permettono di capire che la montagna e’ piena di gallerie, ma entrarci e’ spesso estremamente difficile. La massima parte delle grotte che conosciamo e’ scavata in rocce carbonatiche (calcari e dolomie) che sono costituite essenzialmente da miscele di due sali lentamente solubili in acqua: carbonato di calcio e carbonato di magnesio.
Cosa sono le rocce carbonatiche?
Si tratta di grandi masse di carbonato di calcio e magnesio depositate sul fondo di antichi mari. I piccoli organismi che compivano il loro ciclo vitale in prossimità della superficie del mare vi cadevano poi al fondo quando morivano, formando depositi di residui organici (soprattutto gusci e scheletri) spesso cementati dalla deposizione diretta dei carbonati se l’acqua finiva per risultarne sovrasatura. Le vicissitudini geologiche delle decine di milioni di anni successivi hanno poi trasformato questi depositi in rocce e li hanno fatti emergere all’aria. La variabilità delle condizioni di deposizione, dei tipi di organismi e dei successivi eventi geologici capaci di indurne radicali trasformazioni fa si’ che le rocce carbonatiche abbiano caratteristiche molto diverse dall’una all’altra.

Per quale motivo si formano le grotte?
Il motivo fondamentale e’ che la roccia in cui si sono formate non e’ adatta a resistere ai milioni di anni di piogge che subisce perché e’ piuttosto tenera, erodibile, e soprattutto e’ solubile nell’acqua. I ruscelli, all’esterno, incidono la montagna con pareti, forre, canaloni; all’interno, quando invece riescono a penetrare attraverso sistemi di fratture, formano le grotte. In dettaglio però il processo di scioglimento della roccia in acqua e’ molto complesso: dipende principalmente dalla temperatura (cioe’ dal clima, attuale e passato), dalla quantità di anidride carbonica disciolta in acqua, e dalla portata dell’acqua che penetra nel sottosuolo. L’importanza dell’anidride carbonica e’ fondamentale perche’ essa acidifica l’acqua rendendola piu’ aggressiva: le acque piu’ ricche di questo gas disciolto sono quelle che hanno attraversato forti coperture vegetali e le acque piu’ fredde, perche’ la sua solubilita’ decresce al salire della temperatura. Grosso modo si puo’ dire che si tratta di una lotta fra le condizioni che provocano lo scavo delle grotte (acque non sature di sali, e percio’ aggressive) e quelle che causano il loro riempimento (acque sovrassature di sali disciolti e che percio’ tendono a depositarne una parte). Queste ultime provocano percio’ la formazione di concrezioni che possono finire per riempire interamente la cavita’. In questi casi quel che resta di una grotta viene frammentato in tronconi isolati l’uno dall’altro, perfettamente inaccessibili: nei monti in cui troviamo una grotta concrezionata ce ne sono sicuramente molte altre, isolate dall’esterno, bolle d’aria chiuse nella roccia da fantastiche cristallizzazioni. E’ per questa loro tendenza a divenire inaccessibili che le grotte molto adorne di concrezioni (o, all’interno di una stessa grotta, le gallerie fortemente concrezionate) sono rare: il loro sviluppo e’ un fenomeno che finisce per isolare completamente la cavita’ per poi riempirla completamente.
Dove va a finire l’acqua delle grotte?
Verso le sorgenti, a valle. Il percorso di un ruscello all’interno di una montagna e’ all’incirca questo: cade lungo pozzi e ripide e strette gallerie unendosi ad altri ruscellamenti ed ingrossandosi sino ad arrivare ad una quota poco maggiore di quella delle risorgenze, quella che gli speleologi chiamano livello di base, dove spesso ormai il flusso d’acqua si e’ trasformato in un torrente che scorre in ampie gallerie, detti rami attivi. A quel punto la gran parte della caduta attraverso la montagna e’ finita. Li’ l’acqua diventa lenta, poco propensa a erodere, e forma laghi e laghetti. Le nostre esplorazioni in genere si arrestano quando arriviamo dinanzi ad un lago il cui emissario e’ subacqueo, cioe’ un lago nel cui letto vi sono gallerie sommerse nelle quali l’acqua avanza verso le risorgenze. (noi chiamiamo sifoni queste gallerie sommerse). Le stese sono esplorabili esclusivamente tramite attrezzature subacquee da speleosub debitamente formati. E’ una disciplina effettivamente pericolosa, ma che in questi anni sta conoscendo un grande sviluppo grazie anche all’evoluzione delle tecniche di immersione. Un altro sistema, molto piu’ comodo, per sapere come sono fatte quelle zone sommerse e’ studiare in altre grotte i tratti di gallerie che erano sommerse in un lontano passato ma che ora sono fossili e piene d’aria. Ecco le gallerie sommerse alle radici del monte: sono ampie, piene d’acqua lenta, di forma diversa da quelle nelle quali l’acqua precipita: quelle lassu’ sembravano forre, alte e strette, sempre in discesa, mentre queste sono abbastanza tondeggianti e vanno su e giu’ (in genere dolcemente), modellate a salite e discese che si alternano in un modo apparentemente insensato, dimentico della gravita’. Sono quelle che noi chiamiamo gallerie freatiche, cioe’ che si sono formate sott’acqua. Insomma: l’acqua entra e cade lungo forre interne sino alla base del monte, modellato come una spugna in un intrico di gallerie invase dall’acqua. In un qualche punto all’esterno questo gran bacino d’acqua tocca la superficie della montagna e di li’ trabocca: e’ la risorgenza, finalmente. In Italia ne abbiamo di notevoli, fantastiche avventure sommerse. I luoghi dove l’acqua torna a giorno, dopo chissa’ quali percorsi nell’oscurita’, sono sempre molto belli. Oltre che molto belli sono luoghi molto utili, dato che la loro acqua in genere viene captata ed immessa negli acquedotti.

Ci sono grotte non originate dall’acqua?
Si’, sulle pendici dei vulcani. Lo scorrimento delle lave forma delle grotte di un tipo particolare, l’esterno del flusso di lava che corre verso valle si raffredda e cessa di scorrere, venendo a formare un tunnel al cui interno continua a scorrere la roccia fusa (incavernamento della lava). A fine eruzione viene lasciato un tubo di roccia che, una volta raffreddatosi, potra’ divenire percorribile. Le piu’ grandi grotte a “tubo di lava” si trovano nelle Haway e raggiungono sviluppi di oltre 10 km; in Europa ve ne sono di famose alle Azzorre. In Italia, sulle pendici dell’Etna se ne aprono diverse centinaia, alcune delle quali superano abbondantemente il chilometro di sviluppo.
Che condizioni ambientali vi sono in grotta?
Sono, in genere ambienti poco ospitali per l’uomo. La regola generale e’ che l’aria delle grotte e’ satura di umidita’ e con una temperatura praticamente costante: vediamo queste due caratteristiche. L’umidita’. Acqua ed aria in un qualsiasi ambiente chiuso vanno in equilibrio fra loro quando l’aria diviene satura di vapor d’acqua. In grotta, in genere, ci sono entrambi i fluidi, in ambiente chiusi o semi-chiusi: l’acqua ha cosi’ tempo di evaporare e saturare di umidita’ le masse d’aria che fluiscono nella montagna (il fatto che all’esterno, invece, l’aria sia spesso ‘secca’ e’ causato dell’azione del sole e delle precipitazioni). Vediamo la temperatura. Le grotte sono quasi sempre attraversate da grandi flussi d’acqua: grosso modo la loro temperatura e’ quella media delle acque che entrano sottoterra, e dunque, all’incirca, quella media delle precipitazioni (pioggia o neve) in quella particolare localita’. Normalmente, percio’, le variazioni di temperatura da una grotta all’altra sono piuttosto grandi, legate al clima della regione e alla quota. Un po’ di esempi? Le splendide grotte di Sardegna, che si sviluppano prevalentemente al livello del mare, sono intorno ai 20 C, le grotte alpine e nord-appenniniche a mille metri di quota hanno temperature intorno ai 6-8 C, mentre quelle che si aprono intorno ai duemila metri di quota sulle Alpi scendono fino a 1- 3 C. In genere, insomma, in grotta fa piuttosto freddo. Questa e’ la regola, ma ci sono numerose eccezioni legate a situazioni particolari: grotte che si aprono in zone termali possono essere cosi’ calde da impedire o rendere estremamente difficile l’esplorazione (le grotte di Sciacca, in Sicilia, arrivano ad oltre 80 C). E’ invece molto raro incontrare grotte la cui temperatura sia sotto lo zero, anche solo di poco

C’e’ vita nelle grotte?
Certamente, ma attenzione: un ambiente sotterraneo, se fosse completamente isolato, conterebbe un ecosistema incompleto e quindi incapace di sostentarsi perche’ mancante della luce che e’ la fonte primaria di energia dalla quale dipendono tutti gli esseri viventi. All’esterno sono le piante verdi quelle che utilizzano la luce per i processi di trasformazione delle sostanze minerali in sostanze organiche (fotosintesi), innescando tutte le catene alimentari che, partendo dalle piante, passano per i vegetariani e finiscono ai carnivori e ai detritivori. Sottoterra la luce e’ assente e quindi l’ambiente deve per forza dipendere da quello esterno. Da su infatti, mediante veicoli come certi animali esterni, le correnti d’aria, la gravita’ e, soprattutto, l’acqua, vengono immesse nel sottosuolo quantita’ spesso notevoli di materia organica. Qualche volta si tratta di esseri vivi (animali invertebrati, spore, pollini e limi ricchi di batteri e protozoi), ma in genere cio’ che viene trascinato giu’ e’ materia organica morta: detriti vegetali piu’ o meno decomposti, guano, cadaveri di animali grandi e piccoli e cosi’ via. Insomma: il mondo sotterraneo e’ un mondo privo di piante e di vegetariani, si procura materiale energetico ‘filtrato’ dall’esterno ed e’ essenzialmente popolato da animali detritivori e dai loro predatori. Bisogna pero’ sottolineare che le grotte, in questo discorso, costituiscono un concetto antropocentrico, in quanto sono dei vuoti a misura d’uomo, cioe’ percorribili ed esplorabili. Ma i confini tracciati da un rilievo topografico sono solo l’espressione dei nostri limiti esplorativi, oltre i quali un immenso mondo, di gran lunga piu’ vasto di tutte le grotte che ci e’ dato conoscere, si estende a dismisura nel reticolo tridimensionale di micro-fessure, inesplorabile ma esistente in ogni massiccio montuoso. Questo e’ il vero ambiente sotterraneo, il piu’ protetto, climaticamente piu’ stabile e biologicamente piu’ popolato. Le grotte sono soltanto delle comode (per noi) finestre aperte su questo mondo, dei vuoti percorribili che ci permettono di penetrare piu’ o meno profondamente nel sottosuolo e nelle quali gli organismi che ‘escono’ dalle loro piu’ riparate fessure, capitano solo casualmente: ma e’ solo qui che noi, chiamandoli un po’ impropriamente cavernicoli, li possiamo incontrare.
C’e’ sempre buio in grotta?
Si’, nelle grotte c’e’ sempre buio, proprio quell’oscurita’ che riempie qualsiasi oggetto non trasparente. Il buio e’ tanto fisiologicamente completo che se vi si rimane per qualche minuto si finisce per avere difficolta’ a capire se i nostri occhi sono aperti o chiusi. Quel buio fisiologico totale pero’ non e’ assoluta assenza fisica di luce. Ne esistono tracce dovute a particelle di radiazione cosmica che riescono a penetrare nel sottosuolo (dette muoni), che quando attraversano l’aria di una grotta rilasciano un impercettibile segnale di luce; esso pero’ e’ estremamente debole e discontinuo e quindi l’evoluzione ha spinto le forme di vita presenti a fare completamente a meno della vista. Si vede che se la cavano benissimo.
In grotta si riesce sempre a respirare?
Si’, perche’ l’aria di grotta viene continuamente rinnovata con aria esterna che penetra, per motivi che vedremo oltre, dagli innumerevoli piccoli sbocchi verso l’esterno che ha ogni grotta. Anche l’acqua che vi fluisce contribuisce a rinnovare l’atmosfera grazie ai gas disciolti che essa trasporta: questo spiega come mai l’aria di ambienti anche piccoli sia quasi sempre respirabile anche in diramazioni completamente isolate dall’esterno da tratti di gallerie sommerse. Due caratteristiche distinguono l’aria delle grotte da quella esterna: essa e’ quasi sempre satura di umidita’ ed estremamente pura. Queste due caratteristiche sono legate: l’umidita’ e le lievi differenze di temperatura inducono cicli di condensazione ed evaporazione che finiscono per catturare e spostare nell’acqua tutte le particelle in sospensione nell’aria. Ne risulta un’aria fredda, umida e sterile che e’ molto adatta a guarire malattie di tipo polmonare. E’ soprattutto nell’Est europeo che la speleoterapia (letteralmente: cura tramite le grotte) si e’ molto sviluppata: la’ esistono decine di grotte in cui i malati di asma, soprattutto allergica, vengono curati con cicli di permanenza piuttosto lunghi sottoterra. In Italia questo tipo di medicina e’ ancora alla fase iniziale, ma i risultati ottenuti sono gia’ incoraggianti. Non proprio tutte le grotte possono pero’ vantarsi dell’aria che contengono: ne esistono rarissime che hanno aria cattiva perche’ si aprono in zone vulcaniche o perche’ al loro interno vengono trasportati materiali organici che, imputridendo, formano sacche di anidride carbonica. Questo e’ un gas piu’ denso di quelli che costituiscono l’aria e dunque tende ad occupare le parti basse delle cavita’. Perche’ questo accada pero’ occorre che la grotta abbia una sola entrata (con due si formano correnti che rinnovano continuamente l’aria interna) e quindi che sia piuttosto piccola, e inoltre che l’apporto organico sia importante. Una minaccia del genere e’ percio’ presente solo nel caso di pozzi ciechi (eventualmente artificiali) che si aprono in zone con molta vegetazione; e’ quindi un pericolo piuttosto raro in Italia, ma abbastanza frequente in zone tropicali.
Perche’ in grotta fa freddo mentre nelle miniere fa caldo?
Soprattutto perche’ le grotte sono state attraversate per molto tempo da grandi flussi d’acqua “fredda”, mentre le miniere, in genere, no. E’ il flusso d’acqua dall’esterno che, in tempi geologici, finisce per portare la roccia carsificata ad una temperatura prossima a quella media delle precipitazioni meteorologiche. L’acqua che eventualmente e’ presente nelle miniere e’ invece immobile e in equilibrio termico con la roccia, la cui temperatura cresce assai rapidamente con la profondita’, circa trenta gradi per ogni chilometro di discesa. Ad aggiungere caldo al caldo ci pensa lo scavo delle gallerie che puo’ mettere in contatto l’aria con minerali che reagiscono con l’ossigeno producendo calore: solfuri, ad esempio.
Perche’ ci sono correnti d’aria?
Per capirlo pensiamo ad un camino: se il fuoco e’ acceso l’aria al suo interno e’ piu’ calda di quella esterna, quindi meno densa, e tende a salire proprio come capita a quella delle mongolfiere. Si forma cosi’ un risucchio alla base e un soffio dalla sommita’, entrambi tanto piu’ violenti quanto piu’ alto e ampio e’ il camino. Lo stesso capita dentro le montagne; abbiamo visto che l’aria interna ha una temperatura quasi costante, ma quella esterna no: quando l’aria interna risulta piu’ calda di quella esterna (in inverno, ad esempio) le masse d’aria nel monte tendono a salire, mentre d’estate, quando l’interno risulta piu’ freddo dell’esterno, l’aria interna non riesce piu’ a “galleggiare” e cade, facendo si’ che le entrate alte aspirino aria e quelle basse la soffino fuori. Perche’ avvenga questo fenomeno occorre che ci siano molti ingressi, ma le grotte li hanno sempre, anche se spesso gli speleologi ne conoscono uno solo. Come capita nei camini, anche nelle montagne le correnti d’aria sono tanto piu’ violente quanto maggiore e’ la vastita’ della grotta. Questi flussi d’aria hanno normalmente velocita’ di pochi metri al secondo, ma a volte sono estremamente violente: si pensi che in una grotta (Pinargotzu, Turchia) e’ stato misurato un vento di oltre 160 chilometri orari!
Le grotte possono riempirsi d’acqua?
Sono pochissime le grotte che davvero si riempiono, che cioe’ si saturano completamente d’acqua; sono molte invece quelle che in caso di forti piogge sono soggette a piene che allagano zone di passaggio. In esse gli speleologi (si tratta sempre di grotte non aperte al pubblico) possono rimanere bloccati anche per giorni; in questi casi, in genere, la squadra bloccata non corre veri rischi se ha quel minimo di cibo che sempre ci si porta appresso: bisogna, e basta, aspettare. La situazione e’ pericolosa se vi finiscono degli inesperti, che possono decidere incoscientemente di superare il blocco imposto dall’acqua, finendo per rischiare di annegare o di morire assiderati se si sono infradiciati. Proprio per questo in tali casi la squadra di soccorso cerca di raggiungere al piu’ presto gli sfortunati prima che si gettino in queste azioni temerarie.

Le grotte possono crollare?
In tempi geologici si’: crollano, e i massi di crollo vengono disciolti dai ruscellamenti e portati via; ma su una scala umana di tempo la risposta e’ no, non crollano e anzi, le grotte sono molto stabili. La parte percorribile di una grotta sta li’ da centinaia di migliaia di anni, e quella che vediamo e’ proprio la struttura che la montagna ha assunto per resistere all’infinita’ di terremoti che ha certamente subito in passato: solo qualche raro masso pericolante rischia di smuoversi al passaggio dei primi esploratori in zone sconosciute. I crolli antichissimi avvenuti in una grotta, insomma, sono sempre numerosissimi, ma e’ davvero improbabile che se ne verifichino altri proprio mentre noi siamo li’: persino nel caso di violenti terremoti tendono a crollare solo le strutture piu’ recenti, come le concrezioni. A questo proposito, anzi, aggiungiamo che la paleo-sismologia deduce le caratteristiche di antichi fenomeni sismici dal tipo delle concrezioni che sono state rotte in quei casi e che ora troviamo a terra in mezzo ad altre che sono rimaste intatte.
Come si formano le concrezioni?
Si formano quando le infiltrazioni d’acqua che entrano in una cavita’ per qualche motivo si vengono a trovare soprassature di carbonato di calcio: quel che accade e’ che il sale in eccesso “precipita” (il processo inverso dello “sciogliersi”) e si deposita nella grotta. Le concrezioni che si formano sono molto varie e di grande fascino soprattutto perche’ esulano dalla normale esperienza di chi non e’ mai stato in grotta: e’ infatti rarissimo che all’esterno si creino condizioni adatte a formarle. Sono molto varie e complesse anche le modalita’ di dettaglio con cui una goccia d’acqua riesce a diventare soprassatura in quel punto particolare della caverna: vi intervengono evaporazioni, cessioni di anidride carbonica, micro-variazioni di temperatura, correnti d’aria… Le concrezioni sono in genere di calcite, cioe’ di carbonato di calcio cristallino, dato che e’ il sale piu’ abbondante presente nelle acque di grotta. Ma, piu’ raramente, possono esistere anche concrezioni di altri minerali (ne sono stati descritti oltre duecento) di cui i piu’ comuni sono l’aragonite ed il gesso. I processi per i quali in una grotta si formano concrezioni di certi minerali invece che di altri sono molto complessi e, in molti casi, non ben compresi.
In quanto tempo si formano le concrezioni?
Le velocita’ di deposizione delle concrezioni sono legate al dettaglio delle condizioni ambientali che le causano. Variano ampiamente: alle nostre latitudini e con il nostro clima la velocita’ di crescita varia da 3 a 400 millesimi di millimetro ogni anno. In casi particolari le variazioni possono essere ancora piu’ grandi: per esempio le acque termali riescono talvolta a far crescere concrezioni con velocita’ centinaia di volte maggiori dei massimi appena detti. D’altro canto bisogna tener presente che le concrezioni possono smettere di crescere anche per lunghi periodi o addirittura, se le condizioni dell’acqua sono variate a sufficienza, essere parzialmente ridisciolte.
Si puo’ bere l’acqua delle grotte?
La potabilita’ dell’acqua che esce dalle montagne calcaree e’ legata alla sua storia prima dell’assorbimento. In genere l’acqua di grotta non viene filtrata lungo il suo percorso perche’ corre in ambienti di dimensioni molto maggiori delle particelle che eventualmente possono inquinarla, ne’ incontra microrganismi che la purifichino. Bere in grotta, o bere alla risorgenza, e’ percio’ quasi esattamente come bere l’acqua quando entrava sottoterra, cosi’ com’era al momento dell’assorbimento. Alla risorgenza, a valle, si beve acqua di montagna se le zone di assorbimento sono in alta montagna; se invece l’acqua e’ stata assorbita in un’area popolata, dalle risorgenti sgorghera’ all’incirca acqua di fogna.
Si possono usare le grotte per le discariche?
Ma certamente! Vi si possono buttare animali morti, scorie industriali, rifiuti di ogni genere: basta essere disposti a bersi tutto quanto a valle o nelle citta’ alimentate dalla grotta usata come discarica. Quel che e’ certo e’ che l’interno del monte non filtra nulla: cio’ che viene buttato in un buco lassu’ sgorghera’ dalla sorgente quaggiu’, e in genere non ci mettera’ neppure molto tempo. Bisogna tenere bene a mente, infatti, che anche quei profondi pozzi persi su remote superfici di montagne calcaree non sono in comunicazione con il Centro Della Terra o con l’Inferno: comunicano direttamente con le sorgenti; e’ per questo che sottolineiamo sempre molto il fatto che proteggere le grotte e’ anche uno dei modi per proteggere gli acquedotti che ne utilizzano le acque! E’ inoltre importante sottolineare il fatto che oltre meta’ delle acque potabili in Italia (ma la quasi totalita’ nell’Italia Centrale e Meridionale) proviene da montagne carbonatiche, cioe’ da ambienti carsici, e che questa percentuale e’ destinata a crescere a causa del fatto che le altre acque normalmente utilizzate, quelle estratte con pozzi dai terreni alluvionali, stanno divenendo troppo inquinate per essere bevute.
Sono tutte conosciute?
Assolutamente no. Grazie soprattutto alle grandi esplorazioni di questo ultimo decennio, siamo portati a ritenere che solo una minima parte del mondo sotterraneo sia noto: e questo vale anche per le montagne piu’ esplorate. Sembra che in realta’ le grotte siano molto, molto piu’ vaste di quanto gli speleologi possano sperare di esplorare in modo adeguato. Purtroppo pero’ le grotte tendono a formarsi nei nuclei delle montagne senza preoccuparsi di formare anche ingressi praticabili agli uomini, che dunque rimangono bloccati fuori. A rendere ancora piu’ difficile l’accesso all’interno sta il fatto che le rare entrate, quando ci sono, si trovano sempre esposte alla demolizione dovuta agli agenti esterni (frane, piogge, ghiacciai) che spesso tendono ad ostruirle. E’ per questo che molto spesso riusciamo a sapere da vari indizi che nel sottosuolo di una certa zona c’e’ una grande grotta inesplorata nella quale pero’ non abbiamo modo di entrare.
Cosa si intende per grotte turistiche?
Vengono definite “turistiche” tutte quelle cavita’ naturali per la cui visita (sempre guidata e a pagamento) non vi e’ bisogno di attrezzature e abbigliamento speleologico. Perche’ siano possibili queste condizioni vengono sistemati dei camminamenti, generalmente pavimentati in cemento, muniti di ringhiere; le gallerie vengono dotate di impianti fissi di illuminazione. Le grotte che soddisfano solo in parte queste condizioni vengono definite semi-turistiche.
Le grotte turistiche sono grotte rovinate da un punto di vista speleologico?
No, se l’adattamento e la gestione sono fatte con cura. Si ha senza dubbio un’alterazione rispetto alle condizioni originarie ma compito e interesse del progetto e della gestione e’ proprio contenere al massimo queste alterazioni in modo da offrire ad un vasto pubblico una visione del mondo sotterraneo quanto piu’ intatta possibile. E’ pur vero che gli speleologi ‘sentono’ la grotta e possono spaziarvi molto di piu’ di quanto sia possibile in una grotta aperta al pubblico, ma molti particolari sfuggono loro sia per la scarsa illuminazione sia per la difficolta’ del terreno che li obbliga a concentrarsi sull’avanzata. Le grotte sono in genere ambienti molto fragili, sorta di pinacoteche dai quadri delicatissimi, che possono essere facilmente danneggiati dal passaggio di centinaia di migliaia di visitatori: se non si prendono attente precauzioni si rischia di perdere tutto. I camminamenti devono svilupparsi lungo tracciati che non comportino danneggiamenti e si devono impedire sia la formazione di vegetazione alimentata dalla luce dei riflettori sia le variazioni del regime di ventilazione naturale della cavita’. Bisogna anche aggiungere che, sovente, l’operazione di rendere turistica una grotta risulta essere l’unico modo per proteggerla. Infatti capita spessissimo che una splendide cavita’ di accesso relativamente facile, non appena gli speleologi che l’hanno esplorata ne diffondono la notizia, venga saccheggiata da vandali che cercano mineralizzazioni per venderle. La reazione piu’ corretta da tenere nei confronti di chi offre questi poveri tesori delle montagne e’ quella di rifiutarsi di comprarli, ma non basta, come non bastano cancelli o muri che cerchino di impedire l’entrata ai vandali: occorre una sorveglianza continua che protegga quei posti meravigliosi per chi li voglia vedere in futuro. Ricordiamo infine che le grotte turistiche possono permettere sia il finanziamento di ricerche scientifiche altrimenti impossibili, sia un ottimo lavoro di divulgazione speleologica presso il grande pubblico.
Quali sono le grotte principali in Italia?
L’importanza di una grotta e’ legata a molti fattori quali ad esempio: profondita’, sviluppo, antropizzazione, bellezza. La grotta piu’ profonda (cioe’ quella che ha il dislivello maggiore fra la quota interna piu’ alta e quella piu’ bassa), e’ Olivifer (-1210) sul Monte Grondilice, Apuane (MS). La seconda e’ il Complesso Fighiera’-Farolfi-Antro del Corchia, nel Monte Corchia, Apuane (LU): e’ solo una decina di metri meno profonda della precedente, ma ne e’ ben piu’ estesa, oltre cinquanta chilometri. Se siamo invece interessati allo sviluppo, cioe’ a quante gallerie la formano, e’ il citato Complesso del Corchia che vince (oltre 50 km di sviluppo), distanziando largamente il Complesso di Piaggia Bella (35 km), nel Marguareis, Alpi Marittime (CN). Forse invece siamo interessati al complesso di un’area: in una montagna carbonatica, infatti, in genere conosciamo moltissime grotte che consideriamo distinte solo perche’ non sappiamo passare dall’una all’altra. Ma questo, per la montagna, e’ un dettaglio irrilevante: in genere si tratta di un’unica, immensa grotta che e’ l’interno del monte. Quale e’ la maggiore, cioe’ quale e’ la montagna nella quale si conoscono piu’ grotte? Attualmente e’ il Marguareis (CN), alle falde del quale sgorgano due grandi risorgenze, Foce e Pis del Pesio. Sono tributari della prima sorgente degli assorbimenti d’acqua dispersi in un bacino di 20 kmq, in cui sono noti circa 65 km di gallerie; nel secondo bacino, meno esteso, conosciamo 18 km di gallerie. Quante ce ne saranno in realta’? Chissa’. Vent’anni fa nella prima area conoscevamo meno di dieci chilometri di gallerie e ne sospettavamo una cinquantina, ma ora siamo gia’ ben oltre: ci saranno, probabilmente, alcune centinaia di chilometri di gallerie percorribili. Ma in Italia ci sono altri monti calcarei ben maggiori, nei quali pero’, sinora, non siamo stati capaci di trovare gran che. Chissa’ in futuro. E quali sono quelle che piu’ hanno avuto peso nella storia della speleologia? A questo la risposta e’ piu’ semplice: le grotte piu’ importanti sono quelle del Carso, tanto che “carso” e’ diventata una radice che in tutte le lingue e’ associata alle grotte. Si tratta di un vasto altipiano, adesso condiviso con la Slovenia, tutto traforato di grotte, piccole per gli standard attuali (le maggiori superano di poco i trecento metri di profondita’ e pochi chilometri di sviluppo) ma che, soprattutto nel secolo scorso, hanno avuto un ruolo decisivo nel far nascere la speleologia moderna.

Quali le principali nel mondo?
Ci interessano quelle che attualmente sono piu’ estese? Non c’e’ dubbio: la maggiore e’ una di quelle che hanno tenuto a battesimo la speleologia statunitense, il sistema Mammoth-Flint Ridge, in cui sono note 550 km di gallerie, esplorate in oltre un secolo di ricerche. La seconda e’ una grotta nei gessi dell’Ucraina, la Optimisticheskaja: e’ poco piu’ di un terzo della prima ma con essa condivide il fatto di essere un intricatissimo groviglio di gallerie (esteticamente bruttissime…) esteso su pochi chilometri quadrati di superficie. La terza invece e’ splendida: si tratta della Holloch, in Svizzera, un gran complesso freatico alpino, molto esteso anche in verticale. Se invece ci chiediamo quali siano le grotte piu’ profonde il discorso si complica: ce n’e’, si’, una piu’ profonda di tutte che e’ sulle Alpi francesi, in Alta Savoia, appena di la’ del Monte Bianco. Si chiama Reseaux du Foilly (o Jean Bernard), ed e’ profonda oltre milleseicento metri. Il guaio e’ che le altre grotte di profondita’ comparabile sono molte e il dato della profondita’, a differenza di quello della lunghezza, si presta ad essere variato in poche ore da esploratori decisi e fortunati: insomma, la tabella delle grotte piu’ profonde e’ molto instabile. In sintesi possiamo percio’ dire che le grotte di maggior dislivello attualmente note sono di profondita’ che oltrepassano il chilometro e mezzo, e che (anche in Italia) stiamo curando esplorazioni che ci porteranno vicini ai due chilometri. E quali sono le grotte maggiori possibili? Mah! Le profondita’ massime teoriche, in pratica i dislivelli massimi dei massicci carbonatici maggiori, superano in molte zone i 2500 m (in Pamir, sui Pirenei, ma anche sulle Alpi Lombarde) e in alcuni casi addirittura i 3500 m (Nuova Guinea). Quanto alle lunghezze totali massime possiamo solo fantasticare. Sappiamo che il carsismo in certe montagne crea decine di chilometri di gallerie percorribili in ogni chilometro cubico di roccia; sappiamo pure che alcune risorgenze ricevono acqua da migliaia di chilometri cubici di calcare: e’ dunque probabile che la’ sotto ci siano grotte che si sviluppano per decine di migliaia di chilometri. Sono grandi davvero, no? Un pianeta inesplorato. E’ anche per questo che vogliamo cercare di informare al meglio sulla nostra attivita’: il problema esplorativo che abbiamo scelto di affrontare e’ davvero molto, molto grande e ci fa proprio piacere sentirci capiti.
GLI SPELEOLOGI
A cosa serve la speleologia?
“Servire”? Se si intende “avere qualche immediata utilita’ pratica monetizzabile” possiamo senz’altro dire, con una certa fierezza, che la speleologia in genere non “serve” proprio a nulla, proprio come capita all’astronomia e alla fisica delle particelle. La speleologia e’ una minuscola parte di un vasto insieme di ricerche che vengono condotte avanti soprattutto per se’ stesse, per curiosita’, come del resto si fa con la maggior parte della scienza. La trasformazione dei risultati della ricerca di base in “cose utili” e’ imprevedibile e, addirittura, in genere viene fatta da persone diverse dai ricercatori che hanno “condotto l’esplorazione”. I risvolti pratici delle ricerche speleologiche (ce ne sono piu’ di quanto capita in altri campi, ad esempio, nell’astronomia) vengono incontrati quasi per caso, inattesi. Per esempio: la speleologia aiuta a chiarire la circolazione delle acque nel sottosuolo, a capire la struttura interna delle montagne, permette di incontrare animali interessanti e mineralizzazioni nuove. Ma non e’ per queste cose che andiamo nelle grotte: ci spinge il fatto che riusciamo ad esplorare e descrivere un pianeta nel pianeta. Se questo finira’ anche per risultare “utile” tanto meglio, se no pazienza, sara’ stato molto interessante lo stesso.
La speleologia e’ un “alpinismo all’ingiu'”?
No. Con l’alpinismo ha in comune alcune tecniche di arrampicata (ma gli alpinisti sono molto piu’ bravi), in comune il fatto che nemico principale di alpinisti e speleologi e’ il freddo (ma in grotta e’ un penetrante freddo umido, in montagna un gelo profondo), il fatto che le due attivita’ si fanno in montagna (ma gli alpinisti vanno piu’ in alto). Speleologi ed alpinisti inoltre hanno in comune alcuni materiali e questo fatto, marginale, e’ quello che piu’ induce gli ignari a pensare alla speleologia come ad una variante dell’alpinismo. E’ sbagliato, anche solo perche’ li utilizzano in modo diverso: gli alpinisti si spostano sulla roccia e usano le corde per rimediare alle cadute, gli speleologi in genere rifuggono dalla roccia e si spostano proprio sulle corde (ma, ahime’, la roccia non rimedia alle cadute anche se le arresta…). Ma queste differenze sono piccole: quella essenziale e’ che l’alpinista conosce il luogo geografico dove andra’, l’esploratore ipogeo no. L’uno vuole cimentarsi nel superamento di un problema arduo, l’altro soprattutto vedere le vie dell’acqua dentro una montagna. L’ambiente mentale in cui si muove l’alpinista e’ la difficolta’, quello dello speleologo l’ignoto. Lo speleologo e’ un geografo. Si immagini un continente sempre pieno di nebbie e che sia possibile conoscerne solo le coste, vederne le foci dei fiumi. Se l’alpinismo fosse l’inoltrarsi nelle nebbie dell’interno, risalire i fiumi oscuri sino alle sorgenti, risalire pareti alla cieca, disegnando e rilevando i percorsi e le vie alternative, se fosse misurare vette nel buio scoprendo pareti, valli, connessioni fra le montagne, allora effettivamente la speleologia sarebbe alpinismo all’ingiu’.
Quanti sono gli speleologi in Italia?
Quelli organizzati in societa’ nazionali sono circa duemila, quelli occasionali quattro o cinque volte di piu’. In genere ogni speleologo fa parte di un gruppo speleologico che coordina l’attivita’ esplorativa e promozionale a livello locale: in Italia ce ne sono circa duecentocinquanta.
Cosa fate voi speleologi tutto il tempo che state in grotta?
Soprattutto: ci spostiamo. Le grotte sono spesso molto vaste e purtroppo gli accessi percorribili sono sempre pochi. Questo fa si’ che per raggiungere certe zone dell’interno della montagna occorra percorrere vie molto lunghe, tortuose e faticose: a volte dobbiamo spendere dieci, venti ore di viaggio per raggiungere una certa regione nella quale potremo rimanere in esplorazione solo per poche ore. Il cammino in grotta e’ una sorta di percorso di guerra, una serie interminabile di difficolta’ di poco conto, ognuna delle quali pero’ permette l’avanzata di soli pochi centimetri. La velocita’ di progressione e’ cosi’ sempre molto bassa (in media gli speleologi piu’ veloci superano ogni ora solo due o trecento metri di percorso sub-orizzontale) e percio’ le permanenze tendono in media ad essere piuttosto lunghe, da dieci a venti ore per volta. Naturalmente esistono eccezioni: ci sono sia le escursioni di cinque o dieci ore in grotte facili, sia le massacranti discese di trenta ore senza bivacco (o di molte decine con bivacchi intermedi) in grotte molto difficili.
Come andate attrezzati?
Abbiamo sempre un casco sul quale fissiamo l’impianto di luce, in genere ad acetilene con in piu’ una luce elettrica per situazioni di emergenza. Il resto dell’attrezzatura individuale dipende dal tipo di grotta in cui si entra, ma le grotte che presentano tratti verticali sono la quasi totalita’ e percio’ in genere indossiamo anche imbraghi ed attrezzi da corda: sono simili a quelli che usano gli alpinisti, ma di tipo un po’ diverso. Il vestiario e’ molto variabile, legato com’e’ alle condizioni ambientali della grotta, soprattutto a temperatura e acquaticita’. Di costante c’e’ solo l’indossare un qualche tipo di vestiario termico (possono essere magliette per grotte al livello del mare, tute di pile pesanti per quelle in alta quota, tute stagne per grotte allagate) e, al di sopra di esso, a proteggerlo dagli strappi, una tuta di tessuto molto robusto e poco propenso ad assorbire acqua, in genere nylon antistrappo.
Ci si perde facilmente?
In genere no e, quando capita, e’ facile accorgersene e rimediare. Il cammino, normalmente, e’ lungo ma abbastanza unico: basta un poco di attenzione ai passaggi, curarein andata di guardarsi anche all’indietro nelle zone complicate in modo da saperle riconoscere al ritorno, per essere sicuri di non avere gravi problemi: sempre che, naturalmente, si sia speleologi di una certa esperienza.
C’e’ sempre qualcuno all’ingresso che aspetta che usciate?
Quasi mai, veniamo invece attesi in citta’. Ogni volta che andiamo in una grotta ne informiamo i colleghi del nostro gruppo speleologico che sanno sempre in che grotta (o in che regione sotterranea, nel caso di grotte grandissime) siamo andati. Grosso modo sanno anche l’ora prevedibile di rientro: in caso di ritardo mettono in pre-allarme le nostre Squadre di Soccorso, che poi partono quando il ritardo accumulato e’ diventato eccessivo.Pero’ in questi casi, in genere, vale il detto che “nessuna notizia e’ una buona notizia”: capita molto spesso di accumulare ritardi mentre invece sono rarissimi gli incidenti che realmente facciano si’ che neppure uno della squadra riesca ad uscire a dare l’allarme.

Occorrono doti particolari per fare speleologia?
La normale attivita’ richiede una preparazione atletica molto ridotta: sono sufficienti un fisico sano ed una certa abitudine a muoversi. Il discorso cambia se si vuole accedere alle zone piu’ remote delle montagne perche’ la preparazione (fisica, tecnica e psicologica), puo’ dover essere notevole. Anche ad essa, comunque, si arriva per gradi: “un cammino di mille leghe inizia con cio’ che sta sotto i piedi”. Certo, non bisogna soffrire di claustrofobia, ma e’ una malattia molto rara: frequente e’ invece la paura di soffrirne. E’ un po’ quello che capita anche con le “vertigini”, un’altra sindrome rarissima, che viene quasi sempre confusa con la paura del vuoto che affligge chi non e’ addestrato alle posizioni molto aeree: una paura sana e utile che si impara a vincere quando non serve piu’. D’altra parte una buona parte della speleologia include attivita’ che sono divertenti e fisicamente di tutto riposo: scrivere questo minuscolo libro, ad esempio.
Costa molto fare speleologia?
Le piu’ semplici grotte a bassa quota sono visitabili con quel poco di materiale individuale assolutamente indispensabile (casco, luce acetilene, vestiti robusti, calzature affidabili) con un costo davvero contenuto. Un’attivita’ di maggior livello nella quale si affrontano anche pozzi a quote di media montagna richiede anche un vestiario speciale, attrezzi specifici e vestiario per l’esterno. Possiamo dire che l’intera attrezzatura di uno speleologo medio costa un po’ piu’ di quella necessaria ad uno sciatore e un po’ meno di quella di un alpinista. Oltre ai costi individuali ci sono quelli per gli attrezzi collettivi (corde, chiodi, strumenti ed altro). Di norma sono di proprieta’ dei gruppi speleologici che li comprano suddividendo le spese fra i soci; normalmente si tratta di una spesa pro capite che e’ solo una piccola frazione di quella per l’attrezzatura personale.
Chi paga le spese di queste ricerche?
Di solito la speleologia e’ interamente pagata da chi la pratica. Solo molto di rado, e per problemi specifici, si riescono ad ottenere piccoli finanziamenti per l’acquisto di materiali speciali o per particolari lavori sotterranei.La situazione e’ un poco migliore per le grandi spedizioni speleologiche all’estero i cui costi altissimi vengono parzialmente coperti da ditte promotrici: ma questo puo’ causare la rinuncia a ricerche interessanti ma che non promettono un ritorno di immagine. Negli ultimi anni le Regioni piu’ sensibili ai problemi di conoscenza e protezione del territorio e delle acque si stanno dando leggi che finanziano le attivita’ di pubblicazione e organizzazione dei dati raccolti dagli speleologi, e questo ha indotto notevoli miglioramenti del livello documentativo: ma ancora molta strada ci separa da un utilizzo intelligente delle conoscenze speleologiche.
Quali sono i principali pericoli nelle grotte?
I pericoli che minacciano gli speleologi occasionali e quelli esperti sono di tipo diverso. I primi sono minacciati non tanto dalla grotta in se’ quanto dal fatto che non hanno un adattamento specifico per percorrerla; e cosi’ chi vi si inoltra in modo incosciente rischia di perdersi (perche’ non sa riconoscere i passaggi difficili da trovare al ritorno), di rimanere senza luce (perche’ ha impianti poco efficienti e spesso nessuno di riserva), di scivolare e di farsi male (perche’ non si sa muovere o perche’ la sua luce non illumina con precisione gli ostacoli). Nel caso di chi si avventura in strutture verticali senza adeguata preparazione ed attrezzature specifiche il rischio, altissimo, e’ quello di precipitarvi. Lo speleologo esperto invece e’ al riparo da alcuni di questi incidenti, ma e’ esposto ad altri: citiamo soprattutto le scivolate, di norma provocate dalla stanchezza in discese molto prolungate, le piene e la caduta di sassi nelle zone poco esplorate, che quindi non sono state ancora stabilizzate dal passaggio degli speleologi.
Gli incidenti sono frequenti?
Per fortuna no, per vari motivi. Uno e’ che quelli che vanno nelle grotte non sono molti. Un altro e’ che la maggioranza di chi si accosta alla speleologia lo fa in modo abbastanza coscienzioso, imparando i rudimenti con uno dei numerosi, ottimi corsi che vengono organizzati in ogni parte d’Italia dai locali gruppi speleologici. Gran parte di chi va in grotta, insomma, ha una preparazione specifica. In montagna la situazione e’ un po’ diversa, tanto che solo meno di un quarto degli incidenti di montagna capitano a persone con una qualche preparazione alpinistica: la maggior parte delle vittime e’ costituita da visitatori occasionali, in genere vittime della propria inesperienza. Una montagna con una bella giornata di sole puo’ attrarre chiunque a spingersi piu’ in la’ di dove si sapra’ tornare in caso di peggioramento del tempo: le grotte no, tendono a respingere gli inesperti. C’e’ purtroppo l’altra faccia della medaglia: visto che in grotta gli infortuni capitano quasi esclusivamente a speleologi, possono avvenire in zone molto remote, lontane dalle entrate. E’ a causa di questo che e’ ben raro che un incidente speleologico sia di soluzione semplice: richiede sempre un grande impegno ad un gran numero di soccorritori dai quali si pretende una notevolissima preparazione specifica.
Chi interviene in caso di incidente?
Interviene il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con le sue squadre di volontari, organizzate in modo da coprire l’intero territorio nazionale. Il CNSAS e’ l’organizzazione che, per legge, si occupa dei soccorsi in ambiente montano, e dunque in montagna, in grotta e nelle forre. Ne fanno parte circa seimila volontari incaricati del soccorso alpino e altri seicento che si occupano del soccorso in grotta e in forra. La suddivisione della sezione speleologica e’ grosso modo regionale (se ne puo’ trovare il dettaglio in queste pagine). Ogni delegazione comprende una cinquantina di volontari specialisti che in genere sono sufficienti per rimediare ai guai capitati sul loro territorio. Nel caso di incidenti gravi l’intera struttura nazionale viene messa in allarme ed eventualmente interviene.
Quali sono le difficolta’ di recupero?
Purtroppo le difficolta’ di recupero sono quasi sempre molto grandi. Mentre in montagna l’uso dell’elicottero rende molto spesso l’intervento rapido e risolutivo, in grotta non vi sono scorciatoie: bisogna ripercorrere all’inverso il cammino percorso, anche allargando i passaggi stretti che, superabili da una persona sana, sono invalicabili ad una ferita, chiusa in una barella. Grosso modo possiamo dire che il recupero di un infortunato da un certo punto di una grotta richiede un tempo almeno dieci volte maggiore di quello necessario ad andarci da sani. Se si pensa che attualmente gli speleologi arrivano ad esplorare frequentemente a dieci ore dalle entrate (in casi eccezionali sino a venti ore!), si puo’ capire quanto sia grave il problema posto ai soccorritori del CNSAS.
Chi ve lo fa fare di andare nelle grotte?
Il fatto che e’ molto bello. E’ un’attivita’ nella quale si prende un mucchio di freddo, ci si bagna, si spendono soldi, si fa spesso una fatica veramente bestiale: ma nell’insieme e’ molto bella. Forse il lettore pensera’: “sara’ perche’ vedete dei posti belli, delle belle concrezioni”. Si’, certo, nelle montagne ci sono cose e luoghi estremamente belli, ma non e’ solo (e non e’ tanto) quello il motore: infatti capita molto piu’ spesso di attraversare posti esteticamente dubbi o decisamente brutti e le concrezioni sono sempre rare. Il motore principale che ci spinge sottoterra e’ la possibilita’ di scoprire un immenso mondo inesplorato. Si viene a scoprire che esiste il mistero nel territorio che ti circonda, scopri pareti e precipizi nell’oscurita’ di luoghi impensabili, scavati poco al di sotto di posti solari che facevano credere di essere completamente abbracciabili con lo sguardo. A volte si riesce a vagare in mondi giganteschi e mai visti da esseri umani, ad esplorare i fiumi a monte delle sorgenti, a contemplare il riunirsi delle loro acque nel buio. Si imparano a vedere le montagne non solo dotate di superficie, ma di volume; e diventando astronauti capace di attraversarli. Insomma, spesso ne vale veramente la pena.
Cosa sono le racchette da neve e perchè abbiamo dato loro il nome di "ciaspole"
Un bel panorama invernale, con montagne, abeti innevati e temperature accettabilmente prossime allo zero, è una delle cartoline più ricorrenti nella mente di appassionati ciaspolatori , accompagnatori e guide.
Tutti, o molti, hanno provato almeno una volta a infilarsi quegli zatteroni di plastica per fare un bel giretto di qualche chilometro su neve, per lo più battuta o trasformata. Quando la neve è fresca e polverosa il giretto con gli zatteroni invece si accorcia di molto. Ma quando sono state inventate le ciaspole? Perchè da noi, questi attrezzi a cui abbiamo dato questo buffo nome, sono arrivati solamente una trentina di anni fa?
Andando per gradi comincerei col dire che le “ciaspole” sono alla portata di tutti e non necessitano di una tecnica particolare. Su percorsi facili e sicuri è davvero un’attività per tutti, anche dei bimbi di 8-10 anni. Allacciati gli attacchi, l’avventura può avere inizio per andare alla scoperta di un modo diverso di vivere la montagna d’inverno fuori dalle aree attrezzate . Si dice che “se sai camminare, sai andare con le ciaspole”. Ed è vero, ma c’è bisogno di precisare che camminare a lungo con questi racchettoni ai piedi, non fa così bene alla salute. Generalmente le nostre escursioni non durano più di un paio d’ore e quindi non ci sono problemi, ma un tempo quando le persone erano costrette a muoversi su neve senza sci e dovevano camminare per giorni o mesi interi con pesanti racchette da neve, soffrivano quasi tutte dei seri problemi alle ginocchia e alle caviglie.
La malattia, negli ultimi duecento anni, era chiamata ” mal de raquette” (dal nome raquette, citato per la prima volta nel 1605) visto che in Canada le racchette da neve, per via delle diverse caratteristiche della neve e del terreno, erano molto più popolari che da noi in Europa. Furono poi i cacciatori di pelli e commercianti francesi, i famosi coureurs des bois, a dare il nome “raquette” a questi attrezzi, per il fatto che erano fatte con una rete, inizialmente di tendini animali, ancorata ad un telaio di varie forme. Il “mal de raquette” era localizzato alle caviglie ed era causato sia dal peso degli attrezzi che dalla pressione dei lacci, che legati saldamente al collo del piede, alla lunga infiammavano la parte.
Le origini delle ciaspole sono remote quanto l’esigenza dell’uomo di muoversi su terreni innevati; per parecchi secoli le racchette da neve hanno rappresentato la sola soluzione praticabile per compiere determinati spostamenti in quei luoghi – dell’America e dell’Asia – dove la neve ricopre l’ambiente per molti mesi all’anno. Infatti, permettono spostamenti sulla neve fresca, poiché la loro dimensione e la loro struttura fanno sì che la superficie calpestata sia maggiore, consentendo così di sprofondare molto meno. Le prime tracce di oggetti simili alle racchette da neve risalgono a circa 30. 000 anni fa e sono state trovate in Canada, dove sembra siano arrivate delle popolazioni di nomadi dalla Siberia, tramite lo Stretto di Bering. L’uso di questi attrezzi poi è andato avanti e oltre ai nativi, agli interpreti e i commercianti, sono stati in particolare i cacciatori di pelli, poi diventati boscaioli, a impiegarle trasformandole in uno strumento indispensabile per la sopravvivenza in caso di abbondanti nevicate. Erano soprattutto i cacciatori di animali di piccola taglia ad avere estremo bisogno di questi attrezzi perchè calzandoli potevano andare a piazzare le loro trappole senza avere l’intralcio degli sci.
Questi attrezzi per camminare sulla neve sono arrivati in Europa nel Seicento, portati dai coloni che rientravano nei loro Paesi dall’America del Nord, dove questi attrezzi erano molto usati. E’ curioso sapere che il primo dizionario a riportare il termine indicante le racchette da neve, risale al 1674 (Oxford English Dictionary). La parola è rimasta uguale: snowshoes.
Da sempre esistono varie forme di racchetta, differenziate per grandezza. Vanno scelte in base alle attività, al tipo di neve e al percorso che cui si appresta ad affrontare. In aree molto pianeggianti come la Scandinavia e il Canada da sempre sono popolari le racchette lunghe, mentre sulle Alpi, caratterizzate da terreni più ripidi (dove la neve è per forza meno profonda) le racchette sono corte e più maneggevoli.
Le forme possono essere molte, le più conosciute sono:
Fagiolo: le prime ma ormai sorpassate, erano a forma proprio di fagiolo, dotate di struttura esterna in legno di frassino o acero e di superficie d’appoggio in cordini intrecciati. Il piede veniva fissato con fettucce e/o cordini.
- Canadesi : le “tear drop” sempre in legno, lunghe (anche oltre il metro) e spesso dotate di coda. Sono ancora oggi ideali per nevi profonde; presentano vari sistemi di fissaggio e ormai sono oggetti di artigianato di lusso per appassionati, visto che realizzarne un paio di buona qualità ci si può impiegare anche un anno.
Mocassino o “zampa d’orso”: sono quelle a forma quasi rotonda, un tempo realizzate con i tendini di caribou o altri cervidi. Il telaio è di frassino e ancora oggi sono utilizzate dai nativi americani e i loro artigiani vendono questo tipo di racchette con successo in tutto il mondo.
- Moderne: di forma intermedia tra le due precedenti, realizzate in plastica o alluminio, sono quelle che ormai vengono utilizzate più diffusamente e che si trovano presso i rivenditori di articoli sportivi ben forniti. Hanno attacchi molto tecnici e con accorgimenti tecnologici, risultando adatte anche su terreni ripidi.
-
Forme e modelli da varie parti del mondo
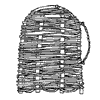
Yugoslavia and Czechoslovakia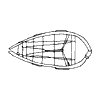
Inuits, St. Lawrence Island, Alaska, U.S.A.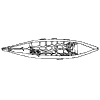
Chukchis, Siberia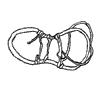
Yokohama, Jap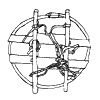
Czechoslovakia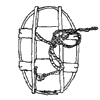
Czechoslovakia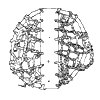
Czechoslovakia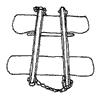
Sweden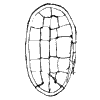
Humenné Region Cekia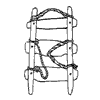
Sweden
In origine le racchette da neve venivano create impiegando tendini o corda di corteccia intrecciata e legno in genere di frassino (resistente e elastico), noce nero americano o nocciolo ( meno resistente, più pesante degli altri due ma di facile lavorazione). In seguito, dagli anni Cinquanta del Novecento questi materiali artigianali sono stati sostituiti da soluzioni industriali in alluminio e poi in plastica: una trasformazione che ha alleggerito di molto il peso effettivo delle ciaspole, contribuendo a renderle popolari. Negli ultimi decenni questi strumenti stanno vivendo un vero e proprio boom e visto che ciaspolare è economico, non comporta tecnica, rischi e preparazione fisica, è proprio uno sport per tutti.
Infine sveliamo perchè in Italia abbiamo dato il nome non di ” ciaspole” a questi attrezzi. Era il 1973 quando per la prima volta in Val di Non (Trentino), venne organizzata la prima Ciaspolada, la maratona sulla neve con le racchette da neve, che in dialetto noneso vengono chiamate “ciaspole”. Da quell’anno in avanti è cronaca….
Buon inverno!
GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE 2022
Quest’anno la Giornata Nazionale del Camminare compie 10 anni. La giornata è sempre stata ricca di iniziative di diverso tipo che hanno avuto al centro il Camminare in tutte le sue declinazioni.
Dal 2020, nonostante la pandemia, la giornata ha mantenuto la sua vitalità ed il suo messaggio, sebbene con modalità ridotte a causa dell’emergenza sanitaria. Proprio nei 2 anni più difficili però qualcosa sembra cambiato in positivo.
Tantissime persone hanno iniziato a camminare quasi quotidianamente per la prima volta nella loro vita. Ci sono dati che parlano di un incremento di circa il 30% di persone che hanno scoperto la dimensione del camminare.
Le persone, oggi più che mai, hanno un estremo bisogno di seguire percorsi di rigenerazione fisica, spirituale e psicologica ed il gesto più antico e naturale del mondo porta grandi benefici ormai consolidati dalla letteratura scientifica.
Ecco perché a dieci anni dalla prima Giornata del Camminare, rappresenta un grande valore non solo per FederTrek, ma anche per il vasto e numeroso popolo dei camminatori.
Dieci anni sono tanti e di cose ne sono successe, è venuto a mancare uno degli ideatori della Giornata, il caro Italo Clementi. A dieci anni da quella straordinaria intuizione noi abbiamo il dovere di raccogliere con gioia, come abbiamo fatto sempre, la sfida di mettere a disposizione la pratica e la diffusione del camminare per aiutare le persone a non perdere la speranza di un mondo migliore.
Una speranza da costruire anche con uno stile di vita sano e non è un caso se l’intuizione della Giornata del Camminare nasce anche dalla conoscenza di studi scientifici consolidati che mettono in luce il valore fondamentale del camminare anche in città.
Una Giornata per riempire le piazze, le strade o i sentieri fuori città di quella gioia di vivere che abbiamo imparato ad apprezzare. Una rigenerazione che ha bisogno di tante cose ma in cui il passo lento può recitare una parte molto importante.
–> Potete trovare le modalità di adesione sul sito https://www.giornatadelcamminare.org per proporre le vostre iniziative sui seguenti temi:
- TEMI: quest’anno, oltre a tutte le iniziative legate al camminare, metteremo in evidenza il TREKKING URBANO, le AREE INTERNE e la promozione dei CAMMINI storico culturali
- AZIONI: per dare forza al cambiamento che auspichiamo proponiamo l’attivazione della società civile tramite il mondo della SCUOLA e della COMUNITA’ EDUCANTE, di ogni ordine e grado, e gruppi organizzati che conducano attività di PULIZIA dei Sentieri e dei Cammini dai rifiuti e, in particolare dalle PLASTICHE.
MARMOLADA, non sarà più come prima…
Sappiamo tutti che muoversi sui sentieri montani ha dei rischi, ma tali rischi sono la motivazione che ci porta e studiarne le dinamiche e a fare il possibile affinché non si tramutino in realtà e tragedia. Gli eventi di oggi dimostrano come sia importante non improvvisarsi ed affidarsi a figure professionali che sappiano condurci in sicurezza.
Ma oggi questo non è bastato con la complicità, probabilmente, di una montagna che sta mutando. Stanno mutando le persone che sempre più percorrono i sentieri che le attraversano, stanno cambiando i segnali che le montagne ci danno e che dovremo imparare a leggere.
Il mondo dei camminatori è esploso negli ultimi 5 anni, complice anche la fame d’aria dopo la pandemia, e ha portato sui sentieri numeri più importanti e persone meno consapevoli. Un bene per l’economia delle aree interne, ma porta con se una più attenta gestione dei rischi e delle “rinunce” quando le condizioni o la preparazione dei camminatori non lo consentono.
La montagna è ormai preda di cambiamenti epocali, l’effetto dei cambiamenti climatici è ormai innegabile e lo si legge nelle rughe dei monti. Un cambiamento che, oltre a ridurre o a far ormai scomparire molti ghiacciai li mina nel profondo, generando insidie mortali per chi gli passa accanto. Difficile è ormai leggere i segni a cui eravamo abituati, il rischio è aumentato anche se è difficile riconoscerlo.
Ormai le montagne non saranno più come prima:
- quando si sciava sui ghiacciai nella bella stagione ed in appennino, senza la neve artificiale,
- quando il ghiaccio conservava le riserve idriche per alimentare la bella stagione lungo la valle,
- quando il ghiaccio cementava le rocce fortificando le vette.
Dobbiamo prendere coscienza del cambiamento in atto, contrastarlo in maniera decisa attraverso l’impegno di ognuno di noi, ma anche sapersi adattare ad un nuovo turismo, distribuito e non legato a interventi massicci per gli sport su neve.
FederTrek tutta si stringe in un forte abbraccio alle famiglie ed gli amici degli escursionisti che hanno perso la vita o sono ancora dispersi sulla Marmolada, un incidente importante che ha visto come vittime persone che stavano seguendo una passione, godendo delle meraviglie che quei monti sanno donare.
In queste situazioni si ribadisce l’importanza ed il ringraziamento al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS che veglia su tutti noi con dedizione e responsabilità e che necessiterà di sempre maggiori risorse per affrontare insieme a noi il cambiamento.
La marcia della pace al Parco nazionale del Vesuvio, organizzata dalle guide AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) della Campania, in un territorio simbolo di Biodiveristà e Resilienza
Una marcia della pace al Parco nazionale del Vesuvio, organizzata dalle guide AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) della Campania, in un territorio simbolo di Biodiveristà e Resilienza
Ieri 28 febbraio 2022, una delegazione di guide Aigae della Campania ha organizzato e partecipato ad una marcia della pace al Parco Nazionale del Vesuvio. Una marcia della pace lungo il sentiero n.9 del Parco Nazionale del Vesuvio, atipica, perché svolta in natura in uno dei territori simbolo di Biodiversità e Resilienza della Regione Campania.
Iniziativa che ha visto il coinvolgimento attivo di adulti, bambini e rappresentanti di altre importanti associazioni ambientaliste del nostro territorio come Greenpeace e Legambiente. Uniti ed in cammino, per dire NO ad ogni forma di guerra o di violenza, rivolgendo l’attenzione alla biodiversità e gli ecosistemi coinvolti in questi conflitti.
“È stato un ottimo momento di scambio e di autoriflessione in cui è emerso il ruolo sempre più cruciale delle risorse naturali nell’equilibrio del nostro Pianeta: l’ambiente e l’energia diventano obiettivi strategici nei conflitti mondiali, di forza e di debolezza nei giochi di potere e nodi critici negli exploit di violenza” le parole di Stefania Santoro, giovane guida campana.
“In questo contesto la diffusione di iniziative che esaltino la bellezza e le peculiarità delle nostre biodiversità diventa un obiettivo sempre più importante per una figura come la GAE, perché la Conoscenza dell’Ambiente è il primo passo verso la sua Salvaguardia.” aggiunge Stefania.
Un appello alla sensibilità di tutti per creare un cordone di uomini, donne e bambini che unisca le nostre montagne in un messaggio di pace.
Stefania Santoro e Ivano Caso in rappresentanza di AIGAE e Wave Explorer, Metadventures, Legambiente Campania, GreenPeace Napoli.
Escursioni a Salina: un 2022 luminoso
Si comincia un nuovo capitolo, confrontandosi ancora una volta con l’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova ogni attività da un paio di anni a questa parte. Nonostante questo, le Eolie, e in particolare Salina, sono sempre state meta privilegiata durante il periodo turistico. Nelle ultime due annate, infatti, i visitatori italiani hanno finalmente scoperto che esiste una meravigliosa dimensione turistica anche vicino casa, capace di offrire sia il mare che la montagna. Il 2021 ha poi portato nuovamente il turismo straniero, che era visibilmente mancato durante l’annata precedente.
L’isola di Salina già da adesso si sta confermando un luogo in cui poter organizzare le proprie vacanze, come dimostrano i movimenti di agenzie e tour operator che – molto saggiamente – stanno persino pensando di intavolare discorsi che riguardino la bassa stagione. Questo perché l’isola ha la possibilità di essere fruita al meglio per buona parte dell’anno e si distingue per la qualità della sua offerta. Tante proposte che riguardano le degustazioni di cibi genuini e vini locali, visite ai musei, il mare… e ovviamente le bellissime camminate che Umarruggiu.it propone tra le montagne, fitte di vegetazione e cariche di Storia. Esperienze da raccontare ai visitatori, che spesso rimangono stupiti da luoghi che non ritenevano potessero esistere su un’isola del Mediterraneo, con tanti aneddoti da assimilare.
Il 2022 si apre carico di una luce migliore, occorre saperne approfittare nel senso più nobile della parola. Vi aspettiamo a Salina, l’isola più verde delle Eolie, il prima possibile!
Michele Merenda
Nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali – ARTVA, pala e sonda
Dal primo gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
Il termine del primo gennaio 2022 è stato fissato dall’art. 43-bis del decreto legislativo, introdotto dal decreto-legge n. 41 del marzo 2021 e poi modificato dal decreto-legge n. 73 del maggio 2021.
Le novità riguardano anche coloro che praticano attività fuori pista, con o senza sci, escursionisti e ciaspolatori. Viene introdotto l’obbligo di dotarsi del kit di autosoccorso composto da ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga), pala e sonda da neve, da utilizzare per le uscite laddove “sussistano rischi di valanghe”.
La norma infatti recita: [… I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso (art.26 – comma 2)…].
Vi esortiamo pertanto ad individuare con la dovuta attenzione la zona dove sarà prevista la vostra proposta escursionistica (scelta del terreno e dei pendii) e seguire attentamente, nei giorni precedenti la vostra proposta associativa, l’evoluzione delle condizioni niveometereologiche nella zona individuata, e in caso di dubbio a modificarla. Nello stesso tempo ad osservare scrupolosamente le indicazioni di legge [dotazione personale per tutti i partecipanti dell’apposito kit previsto (Artva, sonda e pala da neve) laddove sussista il “rischio di valanghe” sul percorso scelto.
Ricordiamo che le trasgressioni potranno essere oggetto di sanzioni da parte delle Autorità preposte.
Sul Sito della Formazione Federtrek è stato programmato, in data 22 dicembre 2021, un corso informativo su piattaforma zoom sulla nuova normativa, valido per tutti gli accompagnatori.
Analogo corso informativo, rivolto a tutti i tesserati Federtrek, sarà programmato nei primi mesi dell’anno.
Chi è l’Accompagnatore di Media Montagna
L’Accompagnatore di media Montagna è la figura professionale nata nel 1989 alla quale compete l’accompagnamento su terreni escursionistici dove non è richiesto l’uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche.
Si diventa Accompagnatore di Media Montagna seguendo un iter formativo che prevede il superamento di prove attitudinali di ammissione alla formazione e il superamento di un corso della durata di 55 giorni (600 ore). Le Guide Alpine fanno anche parte del corpo insegnati.
L’esercizio della professione è subordinato anche al superamento di un Esame di Abilitazione ed all’iscrizione all’Elenco Speciale degli Accompagnatori di media Montagna e successivamente all’iscrizione presso l’Albo professionale delle Guide Alpine della regione di appartenenza.
Il nome può trarre in inganno, l’Accompagnatore di Media Montagna (AMM) non ha nessun limite riguardo alle quote altimetriche in cui svolgere la professione.
Gli AMM oltre agli Aspiranti Guide Alpine e alle Guide Alpine sono gli unici ad essere abilitati all’accompagnamento nei territori montani.
A sancire questo principio è la legge quadro dello Stato sulle professioni della montagna n.06/1989 e successiva legge regionale nr 29/94.
Tutto ciò offre a coloro che si affidano a questi professionisti la garanzia di essere accompagnato da personale preparato, qualificato, e sopratutto in regola con le leggi e con le coperture assicurative che in caso di accompagnatori o guide abusive, non vengono ritenute valide.
Il marchio qui riportato è quello ufficiale degli AMM della Regione Marche
Monti Picentini: la prima Alta Via del Mezzogiorno
Fra il giugno ed il dicembre 1984 mi trovo partecipe di una intensa esperienza che ha per teatro d’azione i monti dell’Appennino della Campania. Un cliente della nostra scuola d’arrampicata, il professor Fabrizio Braccini, ci mette in contatto con la Pro Loco di Acerno, piccolo borgo dell’entroterra fra Salerno e Battipaglia, annidato nei Monti Picentini. Anche sotto suo consiglio, la Pro Loco, guidata da Donato Vece, ha in progetto di creare una Alta via dei Picentini.
«Perduti! Clamorosamente perduti in questi boschi che sembrano senza fine.»
Era solo il primo giorno di lavoro e già si rischiava di lasciare a metà la segnalazione del sentiero. Eravamo scesi nei Picentini un po’ troppo sicuri di noi stessi e ora pagavamo la nostra superbia. Avevamo delle vecchie carte IGM al 25.000 e su di esse Fabrizio aveva tracciato i percorsi che avremmo dovuto segnalare. Una rapida occhiata ci fece decidere che tutto il lavoro si poteva fare in pochi giorni, ma allora non sapevamo ancora niente di quei monti.
Lasciato il litorale campano fra Salerno e Battipaglia entrammo nella terra che una volta fu regno dei briganti seguendo una strada tutta curve che si immerge nel verde di ombrosi valloni e conduce ad Acerno, la nostra base operativa. Il giorno successivo ci vide subito all’opera nel tentativo di aprire il sentiero n. 1, quello che da Volturara Irpina sale al Monte Terminio.
Un facile inizio portò a una strada carrozzabile che percorremmo per circa due chilometri; al suo termine ci immergemmo nel fitto bosco. Un vallone sulla sinistra sembrava coincidere in qualche modo con la lettura della carta. Forse eravamo sulla strada giusta e la debole traccia sul crinale che stavamo percorrendo era abbastanza incoraggiante.
Ogni dieci metri circa entrava in funzione il pennello e un nuovo segnale arancione indicava il progresso verso l’ignoto. «Se non altro – scherzava Giulio – tutti quei segni ci serviranno per poter tornare indietro quando ci perderemo come Pollicino.»
Tutto andò per il meglio fin quasi sotto la cima dove il sentiero si perse e dove, ad aumentare le difficoltà, trovammo la neve che già più in basso, riempiva alcuni canaloni: il fitto fogliame della faggeta impediva al sole di sciogliere il manto indurito e quasi gelato, ma certo non avremmo mai immaginato che in giugno, a soli 1500 metri e per di più nell’Appennino meridionale ce ne fosse ancora un buon metro.
Senza sentiero e senza direzione, dal momento che la neve copriva ogni eventuale segno di passaggio, in mezzo alla fittissima selva, eravamo proprio nei guai.
Per più di un’ora, cercammo a destra e a sinistra, tentando di uscire dall’impasse. Dei sentieri segnati sulla carta e che avrebbero dovuto trovarsi nelle vicinanze, non c’era neppure l’ombra. Anni di abbandono e migliaia di foglie li avevano inghiottiti e riportati alla pendice del monte.
Eravamo alla disperazione: cosa avrebbero detto le tronfie guide del Nord a chi, fidandosi di loro, sperava di creare l’Alta Via dei Picentini?
Fortuna volle che il “vecchio” Giulio potesse scoprire su un tronco uno sbiadito segno giallo e blu che iniziava proprio nei pressi del punto dove avevamo perso ogni traccia. Seguendo i bolli antichi e apponendo i nostri nuovi riuscimmo ad arrivare alla stupenda conca erbosa che sta fra le vette del Terminio. La neve finiva, per lasciare il posto ad un verdissimo prato punteggiato da migliaia di viole e da altri fiori di alta quota.
Dalla vetta di destra la vista era estesissima e sotto di noi potevamo scorgere Volturara e il verde tavolato carsico della Piana del Dragone. Nei nostri giri molte altre volte avremmo visto quei magnifici piani carsici che interrompono un po’ ovunque la continuità del bosco e contribuiscono a fare dei Picentini il più importante bacino idrografico del Meridione.
Ma questi piani non costituiscono certo un problema per il camminatore, mentre tutta la complessa rete di vallette e valloni, creste e cime è un vero labirinto.
Dopo aver rischiato il bivacco sulla SS. del Terminio, raggiunta finalmente dopo ore e ore di marcia, e dopo esserci riposati a San Sossio, il giorno seguente segnammo un sentiero che, partendo dal paese porta anch’esso al Terminio.
Secondo il nostro progetto avremmo dovuto ricollegarci al tracciato del giorno prima in un punto preciso, in mezzo al bosco, dove si trovava una sorta di incrocio marcato da un vecchio ceppo di faggio. Ancora una volta, si partiva senza la certezza di dove si sarebbe andati a finire. Sapevamo che un sentiero avrebbe dovuto esserci, ma in un bel tracciato, chiaro e non infestato da vegetazione, c’era poco da sperare.
Fortunatamente all’inizio dell’avventura trovammo un rude conducente di mulo che stava salendo più o meno nella nostra direzione. Interrogato, ci spiegò che ormai sul monte non c’era più niente o quasi, che i sentieri erano abbandonati e a sua volta ci domandò perchè mai facessimo tanta fatica per ritrovarli visto che nessuno li percorreva. La nostra risposta di certo non lo convinse molto.
Sotto un sole implacabile salimmo con il nostro amico lungo un sentiero quasi coperto dal verde. Arrivati alla mulattiera principale, ci separammo e uomo e mulo salirono verso una ignota destinazione. Noi prendemmo la splendida mulattiera lastricata, a tratti, con blocchi di marmo, e spesso fiancheggiata da bellissime orchidee maculate. Tutto sommato sembrava che questa volta si andasse molto meglio. E invece la mulattiera terminò quasi improvvisamente e noi fummo di nuovo nei guai, cercando un itinerario decente che ci portasse più in alto.
Fu lassù che dal nulla ricomparve il nostro mulattiere che, quasi come il buon genio delle fiaba, ci soccorse, dandoci l’indicazione decisiva per proseguire: «Seguite quel tratto infestato di erbacce e sbucherete su un’area disboscata. Oltre quella troverete il vecchio sentiero per Volturara, seguitelo che per pochi metri e potrete imboccare la deviazione per Colla Castagno». Girato il mulo il genio se ne andò inghiottito dalla foresta e noi, dopo vari tentativi, riuscimmo a riprendere la marcia sul sentiero esatto.
Procedendo la faggeta si faceva sempre più fitta e imponente, ma la mulattiera “teneva” e riuscimmo ad entrare in un tratto di bosco che aveva qualcosa di familiare. Erano circa sei ore che segnavamo quel sentiero sperando di arrivare al sospirato incrocio oltre il quale saremmo tornati a Volturara per riprendere il furgone. Sei ore passate col naso incollato alla carta topografica, ma gli occhi attenti anche a splendidi luoghi ove il ricordo dell’uomo si era perso da anni. Alla fine la nostra pazienza fu premiata: al limite della fustaia sorse improvvisamente il ceppo rinsecchito che segnava idealmente l’incrocio.
Per la prima volta provammo una gioia che non era quella della vetta o del superamento di un difficile passaggio, ma quella della semplice soddisfazione di aver ritrovato quel punto, dopo ore di cammino alla cieca e della certezza di aver compiuto interamente la prima e forse più difficile parte dell’opera. Non la gioia dell’alpinista, ma quella dell’esploratore e del pioniere.
I giorni successivi furono anch’essi dedicati all’improba lotta contro muri di vegetazione, seguendo tracce e cercando di costruire un itinerario bello e agevole.
Ci muovemmo dapprima nel settore dei piani carsici del Terminio, quello dei Picentini occidentali, caratterizzato da forme più aspre e decise. Poi lentamente, segnando sentiero dopo sentiero ci collegammo al cuore del gruppo raggiungendo, attraverso la cima dell’Accellica (1660 m), la grande faglia ove scorre il Tusciano.
L’Accellica è forse la più ricca di storia fra le montagne dei Picentini. Si tratta di un’escursione un po’ impegnativa con alcuni tratti di roccia che, seppure facili, richiedono attenzione. Fra le scure rupi pare si andassero a nascondere i briganti della banda Manzo di Acerno, quando da queste parti sciamavano le squadre dei carabinieri in battuta.
Non trovammo le grotte e i cunicoli dei briganti e neppure quel canyon che, si diceva, attraversavano con una pertica che poi veniva tolta per impedire ai gendarmi di raggiungerli.
Tuttavia fra la nebbia impalpabile che ogni mattina incappucciava la vetta, sorgevano magnifiche e spettrali visioni che rendevano tutto misterioso e affascinante.
Sotto l’Accellica sta Acerno, il piccolo paese che per la sua posizione può essere a ragione considerato la capitale del gruppo montuoso. Il collegamento fra Acerno e l’Accellica lo facemmo tentando di ripetere il sentiero percorso dall’intellettuale alpinista Giustino Fortunato, nel corso della sua ascensione alla vetta.
Purtroppo l’intrico delle nuove strade, i disboscamenti e le tracce lasciate ovunque dal bestiame ci resero la vita impossibile e di certo il vecchio sentiero non fu percorso che in parte. A tutto ciò bisogna aggiungere che Fortunato nel suo L’Appennino della Campania (1884), non è certo stato prodigo di informazioni al riguardo.
Tuttavia collegando i vari tracciati ne uscì un itinerario molto interessante. Si inizia dalle rovine della terremotata e sfortunata chiesa di San Donato, passando poi fra i piccoli orti di Acerno. Per i pascoli e i boschi della Serra San Donato, si perviene infine alla grande cresta sommitale.
Oltre Acerno, verso Sud, la nostra fatica si concluse con la memorabile traversata del Polveracchio (1790 m) che, con una spettacolare cavalcata, ci portò fino a Senerchia. Per la sua posizione il Polveracchio è forse la più panoramica vetta dei Piacentini orientali. Dalla sommità lo sguardo spazia fino al golfo di Napoli a Nord e al Pollino verso Sud. La sua cresta, quasi totalmente libera da piante è un giardino fiorito dove si trovano numerose specie di fiori rari. Per più di un’ora camminammo fra orchidee gialle (orchis pallens) e viole che ci accompagnarono fino alla vetta.
Al termine di dieci giorni passati fra questi monti non potevamo che restare stupiti da ciò che avevamo visto, dalla natura ancora spesso incontaminata che si trova in molte zone, dalla particolare bellezza della caotica orografia.
Nonostante il sudore, le faticacce, la rabbia per i sentieri quasi introvabili, ci eravamo innamorati dei Piacentini e certo saremmo tornati per finire con due trasversali la nostra Alta Via.
Dicembre 1984.
Eccoci ancora ad Acerno per concludere. Il tempo non è dei più favorevoli, ma vogliamo iniziare subito il lavoro anche perché abbiamo solo sei giorni di tempo prima di tornare a casa, richiamati da altri impegni.
L’inverno è già sceso sui monti, i faggi formano una grigia patina che ricopre le pendici e i rigagnoli più magri d’acqua sono già ghiacciati.
In mezzo a un nebbione fittissimo tracciamo la prima trasversale, quella che dal Montagnone di Nusco (1493 m), attraverso il Cervialto (1809 m), arriva ad Acerno. Due giorni di umidità continua, ma senza pioggia, hanno fatto da preludio a quella che si è rivelata la nostra più bella giornata fra i Picentini: quella che passammo sui Mai. Infatti, dopo la prima trasversale toccava ora al collegamento fra i Monti Mai (1607 m) e l’Accellica.
La lunga cresta dei Mai è veramente stupenda e offre il più bell’itinerario della zona anche se richiede attenzione sempre desta. Si tratta di una lunghissima camminata che si sviluppa per oltre 12 chilometri sul crinale di una cresta prevalentemente rocciosa.
L’alba è stata stupenda con il sole radente che creava un magico gioco di luci fra le rocce e le piante mentre verso la piana di Battipaglia lievi nebbie iridescenti entravano dal mare facendo emergere ogni rilievo come fosse un’isola.
Ora il sole ha compiuto il suo cammino e assieme a lui noi ci avviamo alla fine del nostro. Di fronte il Terminio mostra tutto il suo possente versante meridionale. Rocce e pilastri sporgono da quella gigantesca ferita del monte che è il Vallone Matrunolo. A sinistra del vallone, una strada porta alla grotta dell’eremo di San Salvatore: sembra l’unica via d’accesso anche a quelle pareti che appaiono quasi inavvicinabili.
Mentre la luna sorge dal Varco del Faggio e il sole appena tramontato colora di rosa il Terminio noi ripartiamo dalla chiesa di San Michele dopo esserci un poco riposati.
Certo non si poteva sperare una conclusione migliore per la nostra fatica e per l’Alta Via dei Monti Picentini.









